 Sulla via Nazionale, proprio in centro a Malalbergo, a pochi passi sia dal
Sulla via Nazionale, proprio in centro a Malalbergo, a pochi passi sia dal
Municipio (alla sua sinistra) che da Palazzo Marescalchi (alla sua
destra), sorge un palazzone adibito a Centro Commerciale.
Però tutti sanno che lì, tempo fa, c’era il mulino.
Parecchi
abitanti ne serbano ancora memoria e per questo ricordo non importa
scomodare i soliti “anzianiâ€. Tuttavia questa reminiscenza
riguarda l’edificio
(alto, imponente, con il suo lato ovest a forma semicircolare) ma non
l’opificio
vero e proprio nella sua attività originaria della molitura: e ciò
in quanto le macine cessarono il loro nobile lavoro circa
sessant’anni fa (1).
Ma
ci vengono spontanee due domande: che cos’è il mulino e perché ha
questo nome? In verità il mulino è uno strumento che produce un
lavoro meccanico, derivante dallo sfruttamento di una forza, sia essa
l’energia elettrica, o l’acqua, o il vento, oppure una forza
animale o umana. La somiglianza delle due parole
mulino
e mulo,
(il primo, nell’italiano corrente, non è però, grammaticalmente,
il diminutivo del secondo) ci richiama subito alla mente la forza
continua e remissiva di questo equino ibrido, così adatto a fornire
energia-lavoro di carattere animale, motrice ideale di tutta la
struttura. L’etimologia, al contrario, ci conduce al verbo latino
molĕre,
cioè macinare, ed all’altro termine latino mola,
vale a dire a quella grossa pietra circolare che stritolava i chicchi
di cereale. Sarebbe quindi forse più giusto usare il termine molino:
ma
ormai questa parola da parecchio tempo risulta in disuso.
Vorremmo
qui rammentare al lettore l’importanza che il mulino ha avuto nei
tempi passati allorquando la sua presenza si rivelava essenziale per
l’economia -ed anche per la vita stessa- di un territorio: ecco
perché, al fine di renderlo in grado di poter servire una zona molto
vasta, avrebbe avuto bisogno di una forza costante e poderosa, che
sostituisse ed amplificasse la trazione animale.
Queste
nostre distese così pianeggianti e poco ventose c’inducono infatti
a pensare che in tempi assai remoti venisse sfruttata soltanto
l’energia animale per questo tipo di lavorazione cerealicola;
peraltro, non abbiamo notizie dell’esistenza di un tale manufatto
nelle zone vicine al paese durante l’Età Antica e nell’Alto
Medioevo. A Malalbergo, però, ad un certo punto accadde qualcosa che
favorì la creazione di un mulino in loco: alla fine del XIII secolo
divenne cioè operativo lo stanziamento concesso dal “Senato di
Bologna†per costruire l’ultimo tratto verso nord del Canal
Naviglio Bolognese
(precisamente da Pegola fino a Malalbergo) che fu terminato nel 1314
e che portò in paese una vena d’acqua continua e fruibile in tutte
le stagioni, utilizzabile a tale scopo (2). Infatti la grande “peccaâ€
dei mulini ad acqua della “Bassa†bolognese era costituita dal
fatto che, durante i mesi più secchi (per la carenza di acqua) e nel
periodo di gran gelo (per il ghiaccio che ne impediva il
funzionamento) l’attività di molitura, che si svolgeva sui canali
locali, veniva forzatamente ad interrompersi; ecco allora che avere a
disposizione un corso d’acqua “correnteâ€, il quale contrastava
in modo naturale le difficoltà climatiche suddette, costituì un
notevole punto di forza per far sorgere qui un mulino a struttura
stabile e robusta, peraltro disponibile per quasi tutto l’anno.
Difatti,
come ad avvalorare queste nostre considerazioni, s’iniziano ad
avere notizie certe sul mulino ad acqua di Malalbergo soltanto nel
XIV secolo: il documento che ne comprova l’esistenza già in tale
periodo è tuttora conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna
e porta la data del 1378
(3). Lo stesso documento testimonia l’importanza anche dal punto di
vista economico di questo mulino che, nei settant’anni che vanno
dal 1378 al 1448, servì molte località , alcune abbastanza vicine ma
altre ben più lontane (4).
Sappiamo
per certo che questo mulino non era “privato†bensì “comunaleâ€,
che sicuramente funzionava già da alcuni anni e che era inserito
nella Legazione di Galliera (5). Il cereale che veniva triturato più
frequentemente era il frumento, ma erano lavorati pure l’orzo,
l’avena, la segale, la fava e, spesso, altre misture, talvolta le
più svariate; il documento, cui si accennava prima, riferisce
ordinatamente in libbre bolognesi tutte le quantità del triturato
cerealicolo, macinate mese per mese; al contrario la coltivazione e
la raccolta del prodotto venivano quantificate attraverso l’unitÃ
di misura di capacità usata a quel tempo, cioè le “corbeâ€.
Sapendo poi che una corba di granaglie equivaleva a circa 160 libbre
bolognesi e che la libbra bolognese corrispondeva a odierni
chilogrammi 0,3618651 (6), possiamo ben comprendere che la produzione
di cereali di queste zone, pur se nemmeno lontanamente confrontabile
con le rese odierne, era per quei tempi abbastanza ragguardevole (7).
E tutto ciò è ricavabile dalle complessive moliture annuali sia del
mulino di Malalbergo sia degli altri mulini dei paesi di questa
pianura (8).
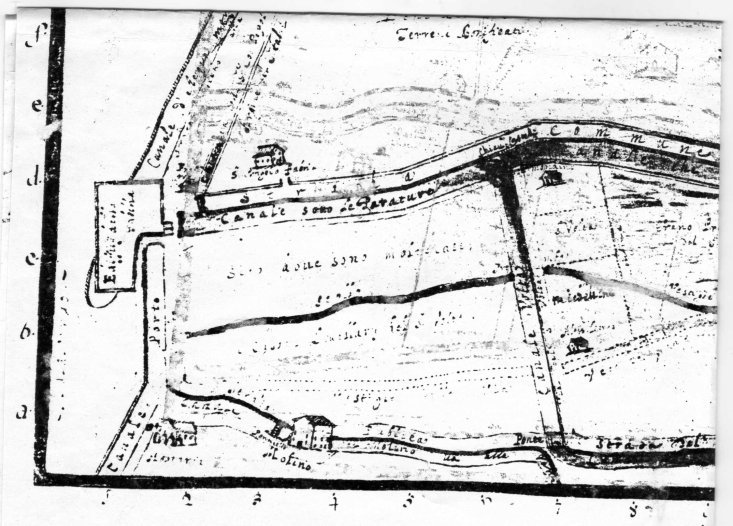 Abbiamo
Abbiamo
inoltre rintracciato una cartina idro-corografica del paese di
Malalbergo e dei suoi dintorni datata 4 luglio 1692, nella quale si
evidenzia la dislocazione dell’opificio proprio ai bordi del
braccio-ovest del Navile (9); quel manufatto riportato sulla carta di
cui abbiamo testé parlato, testimonia chiaramente che tale
deviazione era stata costruita appositamente per sfruttare la forza
dell’acqua in funzione della macinatura.
Nell’anno
1775 venne costruito il Sostegno
di Malalbergo,
l’ultimo sul Canale Navile verso nord, che andò così a saldare la
Navigazione
Superiore
alla Navigazione
Inferiore
Nei
secoli XVII e XVIII, più che i problemi legati al Canal
Naviglio,
il vero nemico furono le “valli†che circondavano Malalbergo;
queste zone paludose, (in massima parte originate dalla liberazione
del Reno, attuata nel 1604 mediante rottura dell’argine destro e
dal suo effondersi nella ferrarese “Valle San Martinaâ€) sin
dall’inizio del Seicento si erano espanse verso sud in modo
talmente vistoso da dar l’idea di essere pure incontrastabili: il
mulino ne risentì così tanto che per lunghi periodi rimase
inutilizzato e trascurato. Però, dopo la nuova
inalveazione
del
Reno
e la sua immissione nel vecchio Po di Primaro (con il progetto-Lecchi
del 1767) quelle zone vallive che circondavano il paese cominciarono,
col passar del tempo, a ridursi cosicché dalla fine del Settecento
ai primi anni dell’Ottocento la produzione di cereali coltivati in
zona iniziò a riprendersi, concedendo pure fasi di rinnovata
floridezza al mulino ad acqua. Ma per gran parte del secolo XIX, per
problemi legati al Navile (interrimenti dello stesso, insufficiente
caduta d’acqua, infiltrazioni nei muri, deperimento delle strutture
lignee) soffrì di ampi periodi d’inattività ed i vari proprietari
che l’ebbero in carico (quasi tutti esponenti di nobili famiglie
bolognesi) dovettero operare svariati interventi di ripristino o
effettuare indispensabili migliorie. Questi lavori, a dire il vero,
parvero dare nuovo vigore al Mulino di Malalbergo: infatti, nei primi
lustri del Novecento, la ritrovata efficienza molitoria portò ad una
consistente ripresa operativa del mulino tanto che, nei primi anni
Trenta del secolo scorso, si rese necessario costruirne uno nuovo,
più ampio, più moderno ed anche in grado di utilizzare la nuova
forza motrice dell’elettricità , cosa che fece per circa un
ventennio. L’edificio sede del mulino più vetusto (antecedente a
quello di cui si parlava nell’incipit
di questo saggio) fu demolito nel 1955. Il “nuovo†mulino andò a
sostituire completamente il “vecchioâ€, mandandolo così in
pensione: il suo disuso era durato oltre vent’anni.
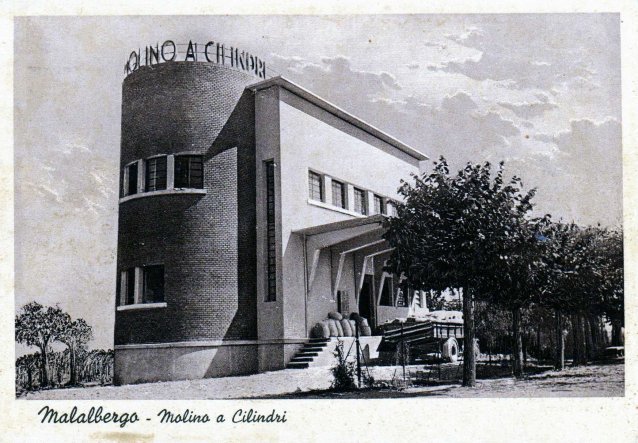 Come
Come
detto poc’anzi, all’inizio degli Anni Trenta del secolo scorso
venne costruito il moderno “molino
a cilindriâ€,
eretto a breve distanza dal suo predecessore e posizionato alla
confluenza di due strade, via Borgo Padova e via Nazionale.
Quest’impianto cessò di funzionare verso la metà degli anni
Cinquanta, diventando dapprima un’officina meccanica e
successivamente sede di stoccaggio di prodotti pertinenti il locale
Consorzio Agrario bolognese. L’edificio fu poi abbattuto l’8
luglio 1991 per far posto ad un nuovo palazzo. Esso fu inaugurato
l’anno dopo, cioè nel 1992, ed ora è contrassegnato dai civici
1/a ed 1/b di via Borgo Padova nel lato-ovest, mentre la facciata,
che guarda su via Nazionale, porta il civico 382. Il manufatto, ora
usato come “Centro Commercialeâ€, ospita svariate attivitÃ
inerenti commercio e servizi.
Dino Chiarini e Giulio Reggiani_______________
Note
-
-
Soltanto
gli ottantenni (ed oltre) possono ricordare il funzionamento del
“Molino a cilindri†che utilizzava come forza-motrice l’energia
elettrica; essi però non possono ricordare quello che funzionava
con l’acqua del Navile. -
Il
Savioli, nei suoi “Annali bolognesi “, riferisce che nell’anno
1301 vennero abbattuti alcuni mulini che ostruivano la navigazione
sul Navile; oltre a ciò, riferisce pure che nel 1314 questo canale
venne riparato e prolungato verso Ferrara. (L.V. SAVIOLI, Annali
bolognesi,
tomo I, pag. 181). Inoltre, sempre nel 1301, gli Altedesi ottennero
dal Senato Bolognese di costruire un mulino sul SÃ vena per macinare
in loco; probabilmente (e questa è una nostra ipotesi) gli abitanti
di Altedo e delle zone limitrofe usufruivano, prima della suddetta
realizzazione, dei mulini a loro più vicini. -
Archivio
di Stato Bologna, Soprastanti,
depositari e conduttori dei dazi,
XXIII – Dazio delle moliture, nn. 179 e 180. -
Le
località che usufruivano di tale mulino erano queste: Pegola,
Altedo, San Pietro in Casale, Galliera, Sant’Alberto, San
Venanzio, San Vincenzo, Podio,
San Prospero, Maccaretolo, Soresano, Pozzo<em>;< em=””></em>;<>
ve
n’erano poi altre più lontane come Granarolo, Budrio, Vedrana,
Cazzano, Mezzolara, Manzatico,
San Martino, Savena, Dugliolo, Dosso, Gorgo.
Dei
due paesi sottolineati,
Podio
è sicuramente riferibile a Poggio Renatico, e Gorgo, che era
l’unico in provincia di Ferrara, è localizzabile in un paese a
pochi chilometri dalla città estense; per quanto riguarda i due in
corsivo-grassetto, Pozzo e Manzatico, non siamo stati in grado di
localizzarli con precisione. Pozzo è un termine troppo vago, che
può riferirsi a qualsiasi località che avesse nelle vicinanze un
fontanile o una buona polla d’acqua; però, analizzando la parola
“Manzaticoâ€, questa ci ha riportato alla mente due cose: 1) il
nome odierno e “popolaresco†di S. Martino in Sovenzano
(frazione del Comune di Minerbio) che viene comunemente chiamato
“San Martino dei Manzoliâ€Manzoli.
-
-
L.
FERRANTI, I
mulini di Galliera e Malalbergo,
pag.
128, in P. GALETTI – B. ANDREOLLI (a cura di), Mulini,
canali e comunità della pianura bolognese tra Medioevo e Ottocento,
Clueb, Bologna, 2009. -
A.
MARTINI, Manuale
di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e
anticamente presso tutti i popoli,
Torino, 1883, pag. 92. -
Però,
a questo punto, il lettore si potrebbe chiedere: “Come mai abbiamo
una produzione così ragguardevole se alla metà del XIV secolo
l’Europa intera fu devastata dalla cosiddetta “peste nera� La
Peste
Nera,
detta anche Morte
Nera,
arrivò in Italia verso la fine del 1347 e la contagiò attraverso
tre direttrici principali: Messina, Genova, Venezia, tre notevoli
città marittime. L’anno di maggior virulenza fu il 1348, ma essa
restò furiosamente attiva fin verso il 1350, per poi diminuire e
successivamente scomparire definitivamente dopo qualche anno.
Essendo arrivata via-mare, dagli ultimi mesi del 1347 le navi che
attraccavano nei porti europei venivano messe in isolamento per 40
giorni (la famosa quarantena,
dal francese “une
quarantaine de joursâ€Decameron
ci
narra le sue novelle e le fa raccontare da dieci giovani che sono
fuggiti dalla città e si sono rifugiati in una villa di campagna,
proprio per sfuggire alla peste. Di certo la Peste Nera provocò
mutamenti profondi nella società dell’Europa medioevale: le
gravissime perdite di vite umane portarono ad una grande
ristrutturazione sociale che ebbe all’inizio enormi effetti
negativi ma, dopo alcuni lustri, anche notevoli effetti positivi. Il
medioevalista e rinascimentalista statunitense David Herlihy
(1930-1991) afferma che dopo tale catastrofe non fu più possibile
mantenere i modelli culturali del XIII secolo; dice pure che, dal
punto di vista economico, il crollo demografico rese possibile, ad
una significativa percentuale di popolazione, accedere a posti di
lavoro maggiormente remunerativi, sia in artigianato che in
agricoltura, quindi sia in città che in campagna. Le Corporazioni
consentirono l’accesso a parecchi nuovi membri fino ad allora
esclusi, mentre per quanto riguarda le attività rurali i terreni
meno redditizi furono abbandonati ed una parte significativa della
popolazione agreste ebbe a disposizione terreni coltivabili migliori
ed anche più ampi. Fondamentalmente per questi motivi, dopo la
peste molte persone poterono godere di un benessere che prima era
certamente irraggiungibile ed il livello economico generale poté
salire in modo tanto significativo. Anche per l’austriaco Egon
Friedell (1878-1938), famoso storico della cultura, esiste uno
stretto rapporto fra i miglioramenti economici successivi alla Peste
Nera e l’avvio del Rinascimento: egli afferma pure che tale
gravissimo accadimento portò ad una profonda crisi, sia delle
certezze della Chiesa sia delle precedenti concezioni dell’uomo e
dell’universo, dominanti fino ad allora. Poté così prendere
avvio una nuova epoca nella storia dell’uomo.
-
Molto
interessante al riguardo è il confronto fra il mulino di Malalbergo
e quello di Galliera, che possiamo ritrovare con dovizia di
particolari nel saggio, già citato in precedenza, di LUCIA FERRANTI
alla pag. 136. -
Carta
idro-corografica della parte terminale della Navigazione
Superiore
del
Navile a Malalbergo, ad opera del perito Stegani, redatta nel 1692.
