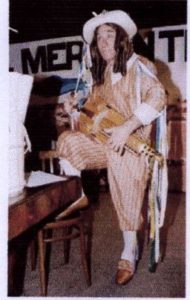Capisco che molti lettori potrebbero restare un po’ interdetti di fronte all’argomento storico che sto per affrontare qui, ma sono in grado di assicurare che la trattazione seguente ha notevole attinenza con questo nostro territorio comunale. Vorrei iniziare, però, dando alcune notizie biografiche su questo grandissimo esponente dell’astrattismo italiano.
Afro Libio Basaldella nacque ad Udine il 4 marzo 1912; compì i suoi primi studi a Firenze ed a Venezia, dove si diplomò al liceo artistico di quella città nel 1931. Successivamente si recò dal fratello Mirko a Roma, città in cui conobbe artisti di fama quali Scipione, Mafai e Cagli, e nello stesso anno a Milano, ove frequentò lo studio di Arturo Martini ed incontrò Birolli e Morlotti.
Nel 1933 si trasferì definitivamente a Roma, dove partecipò, assieme a Guttuso, Scialoja, Leoncillo, Fazzini ed altri, alla II Quadriennale Romana. Nel 1937 tenne la sua prima mostra personale e l’anno dopo fu chiamato alla Biennale di Venezia con due opere, Pastori ed Oreste. Nel 1939 tenne una personale a Genova, intitolata Disegni di Mirko e Pitture di Afro, ed una a Torino, mentre a Roma prese parte alla III Quadriennale. Durante il periodo bellico realizzò svariate opere d’influenza cubista, soprattutto nature morte e ritratti, e definì, attraverso il decennio degli anni ’40, il suo primo periodo astratto: infatti dopo un viaggio a Parigi risentì del “colpo di fulmine†per il cubismo di Picasso e Braque, come pure dei toni spenti di Modigliani.
Nel 1950 si recò a New York, incominciando una ventennale collaborazione con la galleria italo-americana Catherine Viviano, e questo diverso clima culturale lo indirizzò definitivamente verso l’astrazione. Nel 1952 aderì al Gruppo degli 8 e nel 1956 ottenne alla Biennale di Venezia il premio quale miglior pittore italianoThe garden of hope (Il giardino della speranza) per la sede dell’Unesco a Parigi, incluso in una serie di lavori comprendenti opere di Matta, Mirò, Picasso ed altri artisti famosi. Negli anni Sessanta raggiunse la maturità artistica, espose le sue tele nelle più famose gallerie europee ed americane, insegnando anche pittura a Firenze e negli Stati Uniti. Nel 1971 vinse a Roma il Premio Nazionale di Pittura “Presidente della Repubblica”, ma dopo la morte del fratello Mirko e l’insorgere della malattia sopraggiunse in lui un evidente “cambio di rotta artisticoâ€, con lavori molto più immobili rispetto agli slanci del passato e raffiguranti un universo più desolato. Negli ultimi anni di vita tenne svariate mostre personali in Italia ed all’estero.
Morì a Zurigo il 24 luglio 1976. E’ considerato uno dei più illustri esponenti della “Scuola Romanaâ€, assieme a Giorgio De Chirico e Renato Guttuso. Le sue opere sono presenti nei maggiori Musei d’Arte Moderna e nelle migliori Gallerie Artistiche di tutto il mondo.
* Ma cosa c’entra Afro Basaldella con il Comune di Malalbergo? Ebbene, un certo rapporto fra questo grande pittore e Malalbergo c’è¨, poichè esiste un suo quadro di 125 x 160 cm, intitolato “Malalbergo” e datato 1962, che rappresenta molto bene, non solo per i critici, un periodo particolare della sua evoluzione artistica, precisamente dalla fine degli anni ’50 a tutto il decennio successivo, fino cioè agl’inizi della malattia che segnò una svolta nella sua produzione pittorica, come accennato poc’anzi. Io ho potuto vedere il quadro soltanto in fotografia, però posso azzardare questo mio personale giudizio: <Nell’ambito del più moderno astrattismo, le sue forme cromatiche sono concepite in modo che appaiano assai limitate; tutta la composizione gioca sui forti contrasti fra le parti scure e quelle chiare, tanto da sembrare, per intenderci, un “divertissementâ€, uno “svago†bianco-nero. Esso pare ricordare, oltretutto, i coevi studi di Franz Kline, cui viene naturale collegarsiâ€, richiamando pure le idee filosofiche dell’Esistenzialismo>.
Il critico Gabriele Crepaldi, in “Arteâ€, Mondatori Electa, 2005, dice testualmente su questa tela: “Le forme hanno definitivamente perso ogni rapporto con la realtà , sono prive di profondità e sono utilizzate dall’artista per esprimere le proprie emozioniâ€. Prosegue poi: “…assimila l’importanza del gesto pittorico e la capacità di comunicare sensazioni attraverso i colori e i rapporti tra le masse pittoriche. Il suo approccio non è però passivo, anzi, come si può vedere
Leggi Tutto