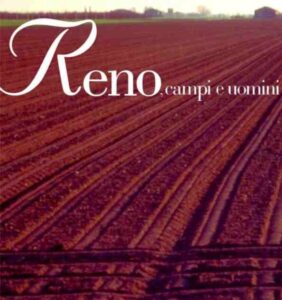
Il sito ufficiale di informazione turistica della Pianura Bolognese copre il territorio di 25 Comuni: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Ozzano dell’ Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Zola Predosa.
L’Ente capofila della redazione è la Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna).
il link di indirizzo è: https://turismoinpianura.cittametropolitana.bo.it/
Altri indirizzi collegati:
https://www.facebook.com/citta.metropolitana.bologna
https://www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste/Eventi_per_Comune
***










